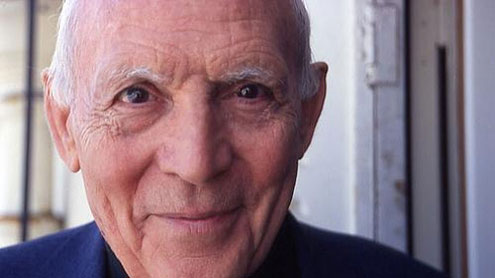
Come epitaffio da incidere sulla tomba, Leonardo Sciascia scelse una misteriosa frase dello scrittore Villiers de l’Isle-Adam: «Ce ne ricorderemo, di questo pianeta». Già: ma da dove? Proprio quando il suo pessimismo, ogni giorno più incalzante, da storico s’era fatto ferocemente cosmico, le non più sufficienti ragioni di Montaigne avevano lasciato il posto a quelle di Pascal, come per uno dei personaggi della terminale Una storia semplice (1989): dato che, ormai, non sembrava più la speranza l’ultima a morire, ma il morire l’ultima speranza. Ecco, se c’è una stazione in cui Vincenzo Consolo non è riuscito a seguire il suo grande maestro, è stata proprio la disincantata distanza, nell’ultimo Sciascia quasi siderale, da quelle delusioni storiche e civili che li avevano entrambi esacerbati. L’attualità politica, infatti – penso alle sue furiose e sempre più preoccupate prese di posizione antileghiste-, lo continuava ad indignare mentre restava il contravveleno, ogni volta più acido, a quel leopardiano male di vivere, che gli era consanguineo, cui non ha mai voluto cedere. Quale fosse il suo modo di stare al mondo, Consolo lo dice bene in Fuga dall’Etna (1993), con la precisa coscienza di quella tradizione – il «romanzo antistorico» (Spinazzola) – che da De Roberto e Pirandello arrivava a Tomasi di Lampedusa, ma anche marcando la sua diversità: «La letteratura per me (…) è il romanzo storico-metaforico. E poiché la storia è ideologia, come insegna Edward Carr, credo nel romanzo ideologico (…), cioè nel romanzo critico. La mia ideologia o se volete la mia utopia consiste nell’oppormi al potere, nel combattere con l’arma della scrittura, che è come la fionda di David, o meglio come la lancia di Don Chisciotte, le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo».
Nato a Sant’Agata di Militello nel 1933, esordisce nel 1963 con La ferita dell’aprile e si trasferisce a Milano nell’anno ideologicamente più simbolico, il 1968. Al Nord come Vittorini: cui guardò da subito, proprio per quella forte tensione verso una parola-giustizia che resti agonistica, sganciata da ogni facile comunicazione, prossima agli ardui approdi della poesia. Ma anche per la naturale disposizione lirica del temperamento, rafforzata dall’apprendistato alla scuola nobiliare del cugino di Tomasi di Lampedusa, Lucio Piccolo, il più esoterico dei poeti italiani: che altro sono quel capolavoro che s’intitola Le pietre di Pantalica (1988) o certe pagine struggenti de L’olivo e l’olivastro (1994), se non il tentativo di riproporre, in vista d’una più aggressiva razionalità e d’un più concreto impegno storico, l’epopea inconclusa delle insondabili e vittoriniane Città del mondo (1967)? Epperò, se le verità di Vittorini erano utopiche, allusive se non illusive, quelle di Consolo sono memoriali, nei modi, come già ho scritto, d’una particolare metrica della memoria, d’una memoria riscattata per forza di prosodia. Di qui il mistero della sua prosa: che una scommessa civile possa vivere come un azzardo della lingua. Cosa che, malgrado l’indubbio plurilinguismo, lo allontana drasticamente dai tantissimi nipotini di Gadda, cui pure è stato superficialmente affiancato.
Dicevo di Piccolo e Sciascia: che poi significa una specialissima alleanza tra malìa e ragione. Quella che sta a monte d’uno dei libri più belli del secondo Novecento italiano: Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976). Il tema è di quelli cruciali per la letteratura siciliana: il passaggio dai Borboni ai Savoia, il Risorgimento tradito. Ma Consolo vi proietta la vicenda di Enrico Pirajno di Cefalù, barone di Mandralisca, autore di un trattato scientifico sulle lumache, collezionista d’arte, liberale illuminato, intrecciandovi quella d’un quadro enigmatico, un ritratto d’ignoto attribuito ad Antonello da Messina. Un anti-Gattopardo, se si vuole: quello in cui un barone che, testimone della rivolta contadina di Alcara Li Fusi, acquista esatta coscienza d’un dramma storico e sociale, azzera in un colpo solo quella teoria di aristocratici reazionari o velleitari, scettici o sofistici, della letteratura isolana. Consolo è partito da qui, razionalista e barocco, con la sua lingua che s’inciela nella tradizione o s’inventra nel dialetto, per smascherare, libro dopo libro, le follie della Storia e del Potere. E ha conosciuto, come Sciascia, una sola forma di smemorata felicità: quella della scrittura, la quale in Retablo (1987) tocca vertici di leggerezza e allegria che solo a volte, e sempre accanto alla moglie Caterina, gli ho riconosciuto nella vita. Confesso che quando ho letto Lo Spasimo di Palermo (1998) ho sofferto: là dove si racconta, dentro l’Italia perduta delle stragi di mafia, la vicenda d’uno scrittore minacciato dall’afasia. Romanzo di parricidi, Lo Spasimo di Palermo, ma anche bilancio drammatico della propria vita, dolorosa e lucida resa dei conti. Ho sofferto: perché ci sentivo un congedo, seppure di molti anni anticipato nel silenzio creativo. E purtroppo non sbagliavo.

